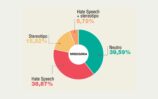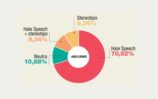Pazienti esperti, capaci di comunicare con il proprio medico e di assumersi la responsabilità della propria salute. Ma anche medici consapevoli, aperti a prendersi cura del paziente e non solo dei suoi organi: la riflessione di un medico, Mario Cerati, che VOX ha pubblicato due settimane fa, ha suscitato diverse reazioni. Eccone una, la lettera di un giovane medico milanese, che porta la sua testimonianza a partire dalle sue esperienze in pronto soccorso e in medicina d’urgenza.
Sono d’accordo con il dottor Cerati: la prima cosa che il malato porta con sé non è la malattia, intesa come “patologia”, ma il suo vissuto…più della metà di quello che racconta al medico è condito da ansie, preoccupazioni, riflessioni personali (spesso aneddoti legati a esperienze passate o di conoscenti), paure rispetto al sintomo, che è spesso qualcosa di nuovo e mai provato prima. Il tutto inserito e riadattato in base al livello culturale e sociale del singolo. In poche parole, ogni paziente ha in mente una sua idea della malattia. Che spesso si discosta da quella degli operatori sanitari.
Come dice Cerati, è questione di “mettere insieme le priorità”: nella relazione medico-paziente si affrontano due “mondi” diversi.
Il nostro lavoro è proprio quello di cercare di interpretare quello che il paziente ci riporta, cercando di placare le ansie e far capire che siamo lì per aiutare (molto spesso il paziente tende a evidenziare i sintomi che lo preoccupano di più, tralasciando dettagli ritenuti di poca importanza, ma per noi fondamentali per arrivare a una diagnosi).
Tutti, in un modo o nell’altro, hanno paura. Hanno poi vari modi di mostrarla.
Bisogna trovare un linguaggio comune, o meglio l’operatore sanitario lo deve trovare adattandosi ogni volta alla persona che si trova davanti: non serve usare termini scientifici se il paziente non li capisce.
Vogliamo parlare del cosiddetto consenso informato, che tante volte non è proprio così “informato”??!
L’aspetto di comunicazione è fondamentale e fa parte del lavoro quotidiano: l’ascolto del malato e del suo vissuto, l’attenzione ai suoi bisogni e alla sue richieste, e la spiegazione costante di quello che si fa, soprattutto quando si tratta di procedure invasive o dolorose.
E’ vero che la relazione cura. I pazienti che si sentono ascoltati e capiscono che c’è chi si prende cura di loro, si fidano del medico. Di conseguenza sono più disponibili a intraprendere terapie e soprattutto, una volta che imparano a conoscere la malattia, a proseguirle nel tempo.
Penso che non sia possibile fare questo mestiere se non si ha voglia di ascoltare.
Non capisco invece quando il dottor Cerati dice che “i medici che si relazionano empaticamente con i malati sono immuni dal burn out”.
Non sono d’accordo su questo punto, secondo me è proprio il contrario. Se si instaura una relazione empatica ci si prende in carico “tutto il pacchetto”: gli aspetti prettamente medico-scientifici e quelli emotivi. Il “farsi carico” di un paziente significa essere responsabile dello stato presente e futuro di quella persona, seppur con una certa quota di sano distacco emotivo.
E i malati, appunto, sono malati: a volte non rispondono alle cure, a volte muoiono. E la frustrazione personale c’è, è inevitabile. Anche se si è “messo il filtro” per le emozioni, nessuno è immune, i pazienti ti “buttano addosso” tutto il loro vissuto. C’è la “sconfitta” scientifica, che si cerca di superare studiando, leggendo, cercando di saperne sempre di più. E c’è quella umana, per la quale purtroppo non ci sono libri. Ci sono i familiari, anche loro con le paure e le aspettative che rimangono deluse.
Il burn out non è solo e prettamente la delusione di non aver “aggiustato il pezzo che non funziona”, l’egoismo del medico che si crede onnipotente che viene frustrato. E’ più la frustrazione del sentire di non aver creato qualcosa di buono.
dott.ssa Giulia Marullo
specializzanda in medicina d’urgenza